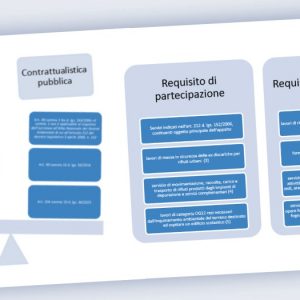A cura dell’avv. Xavier Santiapichi e a cura dell’avv. Gaetano Pecoraro
Una recente sentenza della Corte d’Appello de L’Aquila (n. 304 del 02/03/2015) ha riaperto il dibattito in ordine alla natura giuridica delle società “in house”.
Nel decidere un reclamo proposto contro la sentenza di fallimento di una società, riconosciuta dalla Corte come “in house”, ha ritenuto di seguire “l’orientamento che parifica, in qualche misura, le società in house agli enti pubblici, con il conseguente impedimento alla fallibilità delle stesse”, così revocando il dichiarato fallimento.

Il modello dell’in house providing nasce a livello comunitario, al fine di verificare la legittimità delle prassi in essere in alcuni Paesi dell’Unione, di procedere all’affidamento di commesse pubbliche in via diretta, senza apertura al mercato.
Molteplici sono le sentenze che, nel corso di questi anni, la Corte di Giustizia delle Comunità europee è stata chiamata a pronunciare, ed in ognuna di esse sono state affermate, e ribadite, le coordinate entro le quali fosse legittimo riconoscere tali affidamenti.
Principio generale, a livello comunitario, è quello secondo cui, ai fini dell’applicazione delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici previste dalla direttiva 2004/18, è sufficiente che un contratto a titolo oneroso sia stato stipulato, da una parte, da un’amministrazione aggiudicatrice e, dall’altra, da una persona giuridicamente distinta da quest’ultima (sentenza Teckal, causa C-107/1998).
La deroga “in house” è stata giustificata a livello comunitario per il fatto che un’autorità pubblica, che sia un’amministrazione aggiudicatrice, ha la possibilità di adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa incombenti mediante strumenti propri, amministrativi, tecnici e di altro tipo, senza essere obbligata a far ricorso ad entità esterne non appartenenti ai propri servizi, e che tale deroga possa essere estesa alle situazioni in cui la controparte contrattuale è un’entità giuridicamente distinta dall’amministrazione aggiudicatrice, qualora quest’ultima eserciti sull’affidatario un controllo analogo a quello che essa esercita sui propri servizi; a condizione tuttavia che tale entità realizzi la parte più importante della propria attività con l’amministrazione o con le amministrazioni aggiudicatrici che la controllano (sentenza Stadt Halle e RPL Lochau, causa C-26/03, punti 48 e 49).
L’istituto del “controllo analogo” è stato poi, via via, puntualizzato: la Corte ha rilevato che deve trattarsi della possibilità per l’amministrazione aggiudicatrice di esercitare un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti dell’entità affidataria e che il controllo esercitato dall’amministrazione aggiudicatrice deve essere effettivo, strutturale e funzionale (v., in tal senso, sentenza Econord, C‑182/11 e C‑183/11, EU:C:2012:758, punto 27 e giurisprudenza ivi citata). Per poi precisare che, a determinate condizioni, il «controllo analogo» può essere esercitato congiuntamente da più autorità pubbliche che possiedono in comune l’entità affidataria (v., in tal senso, sentenza Econord, C-2012/758, punti da 28 a 31 e giurisprudenza ivi citata).
La preoccupazione più volte espressa dalla Corte comunitaria è quella di evitare “un’elusione dell’applicazione delle norme del diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici o di concessioni di servizi, dal momento che una presenza puramente formale nella compagine di tale entità o in un organo comune incaricato della direzione della stessa dispenserebbe detta amministrazione aggiudicatrice dall’obbligo di avviare una procedura di gara d’appalto secondo le norme dell’Unione, nonostante essa non prenda parte in alcun modo all’esercizio del «controllo analogo» sull’entità in questione (v., in tal senso, sentenza del 21 luglio 2005, Coname, C‑231/03, Racc. pag. I‑7287, punto 24)” (sentenza Econord).
A livello nazionale, le coordinate entro cui si è ritenuto legittimo il ricorso al modello dell’in house sono state scolpite dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 1 del 03 marzo 2008, che ha di fatto richiamato e ripercorso gli orientamenti del Giudice comunitario, fino ad arrivare alla recente sentenza del Consiglio di Stato, 28 luglio 2015 n. 3716 in cui si osserva che “…tutta l’elaborazione giurisprudenziale sull’in house providing, europea ed interna,si è formata in relazione ad enti di diritto privato a vario titolo controllati da amministrazioni pubbliche, quali in particolare società, consorzi, aziende (in particolare la sentenza “capostipite” Teckal della Corte di giustizia, 18 novembre 1999, C-107/98), e, da ultimo, associazioni senza scopo di lucro (Corte di giustizia, 19 giugno 2014, C-574/12), mentre non si registrano pronunce riguardanti enti pubblici strumentali.
Le ragioni sono da ricondurre alle ontologiche differenze tra questi ultimi, sopra delineate, ed i soggetti di diritto privato, i quali si contraddistinguono rispetto ai primi per la disponibilità del fine da parte dei partecipanti – elemento incompatibile con il carattere doveroso del compito di interesse pubblico attribuito ad enti strumentali, e per l’assenza di meccanismi di funzionamento interno in grado di assicurare alle amministrazioni partecipanti le prerogative della pubblica autorità ad esse riconosciute sul piano dell’ordinamento generale (come di recente statuito dalle Sezioni unite della Cassazione: ord. 23 gennaio 2015, n. 1237)”, per poi aggiungere che “… è insito nella decisione di affidare un servizio in house l’idoneità dell’ente strumentale a svolgerlo compiutamente, potendosi giustificare la deroga all’obbligo della gara, appunto, solo in virtù di una capacità di autoproduzione interna mediante strutture su cui l’autorità pubblica affidante ha un controllo di tipo organico analogo a quello svolto sui propri uffici.
Per contro, il ricorso ad enti formalmente già istituiti ma privi delle necessarie risorse operative, tecniche e strumentali riproduce lo schema di base dell’amministrazione pubblica che per svolgere le proprie funzioni deve procacciarsi i mezzi relativi presso il mercato”.
Su tali coordinate ermeneutiche si è innestata la sentenza 25 novembre 2013, n. 26283 delle Sezioni Unite della Cassazione, (richiamata dalla Corte d’Appello de L’Aquila nella decisione 304/2015) che, nel decidere una questione di giurisdizione, ha stabilito che “La Corte dei conti ha giurisdizione sull’azione di responsabilità esercitata dalla Procura della Repubblica presso detta corte quando tale azione sia diretta a far valere la responsabilità degli organi sociali per danni da essi cagionati al patrimonio di una società in house…”, ritenendo che, ricorrendo i presupposti declinati a livello comunitario, “l’uso del vocabolo società qui serve solo allora a significare che, ove manchino più specifiche disposizioni di segno contrario, il paradigma organizzativo va desunto dal modello societario; ma di una società di capitali, intesa come persona giuridica autonoma cui corrisponda un autonomo centro decisionale e di cui sia possibile individuare un interesse suo proprio, non è più possibile parlare”.
Si può ben comprendere allora, come seppure dettata in tema di riparto di giurisdizione, i principi enunciati abbiano dato nuova linfa ai sostenitori della tesi della soggettività pubblica delle società in house, con tutte le conseguenze derivanti, in primis, quella dell’applicazione dell’art. 1 l. fall., per il quale “Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici”.
Cioè a dire, se una società in house non è una società, allora non è soggetta al fallimento.
Ad avviso di chi scrive, una simile conclusione non è accettabile, per una molteplicità di ragioni.
Perché ricorra il modello derogatorio dell’in house, è necessario che l’affidamento diretto venga operato dall’Ente pubblico in favore di un soggetto giuridicamente distinto da sé, e di diritto privato che, rispetto a quello di diritto pubblico, si caratterizza per la libertà del fine perseguito.
Se, allora, l’affidatario in house è un soggetto di diritto privato, esercente attività commerciale, ne consegue la sua sottoposizione alle ordinarie norme del diritto civile, poste a presidio non solo dell’interesse pubblico, ma di quelli dei terzi.
Non è un caso che l’ordinamento, al fine di evitare la creazione di sacche di impunità (o, a dire con il Giudice comunitario, l’elusione delle norme a presidio del libero mercato), ha introdotto una norma di interpretazione autentica (cfr. Cass. SS.UU. ord. 23 gennaio 2015, n. 1237) secondo cui “Le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque la disciplina del codice civile in materia di società di capitali” (art. 4 comma 13 d.l. 6 luglio 2012 n. 95)
Nella richiamata ordinanza delle Sezioni Unite si è autorevolmente osservato che “già la Relazione al codice civile del 1942, nell’illustrare la disciplina delle società partecipate dallo Stato, affermava: “…. in questi casi, è lo Stato medesimo che si assoggetta alla legge della società per azioni, per assicurare alla propria gestione maggiore snellezza di forme e nuove possibilità realizzatrici; la disciplina comune della società per azioni deve, pertanto, applicarsi anche alle società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici, senza eccezioni, in quanto norme speciali non dispongano diversamente” (n. 998)”.
La circostanza che un soggetto di diritto privato possa operare in ambiti pubblicistici, e che per tali ultimi fini, sia assoggettato a norme ad hoc (art. 3 comma 26 d. lgs. 163/2006 in tema di “organismo di diritto pubblico”) non depone per il suo mutamento di natura: si è osservato da parte del Supremo Giudice di legittimità che “è proprio dall’esistenza di specifiche normative di settore che, negli ambiti da esse delimitati, attraggono nella sfera del diritto pubblico anche soggetti di diritto privato, che può ricavarsi a contrario, che, ad ogni altro effetto, tali soggetti continuano a soggiacere alla disciplina privatistica” (Cass., sent. 27 settembre 2013, n. 22209).
E’ sempre il Supremo Consesso a confermare la natura privatistica delle società in house, osservando come “la finalizzazione della spa alla gestione in house di un servizio pubblico locale, come nel caso di specie, non muta la natura giuridica privata della società con riguardo alle ricadute previdenziali dei rapporti di lavoro, ma assume rilievo nell’ordinamento nazionale e comunitario con riguardo al mercato e alla tutela della concorrenza” (Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 10 gennaio 2014, n. 380).
Cioè a dire, alle società costituite secondo le norme del codice civile, si applica lo Statuto dell’imprenditore commerciale, salve eventuali norme eccezionali che, in quanto tali, sono di stretta interpretazione, e non suscettibili di applicazione analogica (art. 14 delle “preleggi”).
La tesi contraria che vorrebbe, per le Società costituite da Enti pubblici, una applicazione random delle norme civilistiche, da un lato si scontra con il principio immanente nel nostro ordinamento, e codificato dall’art. 4 l. 20 marzo 1975, n. 70, secondo cui “nessun nuovo ente pubblico può essere istituito o riconosciuto se non per legge” (per la tesi qui avversata si consentirebbe, di fatto, l’istituzione convenzionale di nuovi enti pubblici, tale essendo la natura del “contratto” di società), e dall’altro lascia all’interprete l’individuazione, volta per volta, delle disposizioni applicabili, secondo criteri assolutamente arbitrari, del tutto incompatibili con l’esigenza di certezza dei rapporti giuridici e di tutela dei terzi.
In assenza di disposizioni contrarie (che non si rinvengono), anche le società totalmente o parzialmente partecipate (in house o non) da Enti Pubblici devono essere assoggettate allo statuto dell’imprenditore commerciale, con tutte le conseguenze da ciò derivanti: in primis, l’assoggettabilità a fallimento ex art. 1 l. fall.
Si tratta della piana conclusione cui è pervenuta la Suprema Corte con la sentenza 22209/2013, statuendo “che la scelta del legislatore di consentire l’esercizio di determinate attività a società di capitali – e dunque di perseguire l’interesse pubblico attraverso lo strumento privatistico – comporta anche che queste assumano i rischi connessi alla loro insolvenza, pena la violazione principi di uguaglianza e di affidamento dei soggetti che con esse entrano in rapporto ed ai quali deve essere consentito di avvalersi di tutti gli strumenti di tutela posti a disposizione dall’ordinamento, ed attesa la necessità del rispetto delle regole della concorrenza, che impone parità di trattamento tra quanti operano all’interno di uno stesso mercato con le stesse forme e con le stesse modalità”, ritenendo di non poter condividere la tesi “di recente avanzata anche nella giurisprudenza di merito, che vi sono società partecipate aventi sostanziale natura giuridica pubblica, desumibile in via interpretativa da taluni indici (in linea di massima, e di volta in volta, ravvisati in limitazioni statutarie all’autonomia degli organi societari, nell’esclusiva titolarità pubblica del capitale, nell’ingerenza nella nomina degli amministratori da parte di organi promananti dallo stato, nell’erogazione di risorse pubbliche per il raggiungimento dello scopo), le quali vanno equiparate ad ogni effetto (e dunque anche ai fini della loro esenzione dal fallimento) agli enti pubblici”.
Per i Supremi Giudici va “escluso che peculiarità, tali da giustificare l’equiparazione ad un ente pubblico di società a partecipazione pubblica, si rinvengano sul piano del soggetto, ossia dell’ente giuridico “società”, e del modo in cui sono disciplinati la sua organizzazione ed il suo funzionamento, e i rapporti esistenti, al suo interno, fra i diversi organi che vi operano. E ciò vale anche nel caso in cui norme legislative o statutarie pongano limiti alla autonomia degli organi deliberativi, posto che la volontà negoziale della società pubblica, pur se determinata da atti propedeutici dell’amministrazione, si forma e si manifesta secondo le regole del diritto privato. Ad analoga conclusione deve giungersi avuto riguardo al piano dell’attività, cioè dei rapporti che la società, in quanto soggetto riconosciuto dall’ordinamento come dotato di una propria capacità giuridica e di agire, instaura con i terzi. Eventuali norme speciali che siano volte a regolare la costituzione della società, la partecipazione pubblica al suo capitale e la designazione dei suoi organi, non incidono, infatti, sul modo in cui essa opera nel mercato nè possono comportare il venir meno delle ragioni di tutela dell’affidamento dei terzi contraenti contemplate dalla disciplina privatistica”.
Si tratta di conclusioni ormai acquisite dalla giurisprudenza di legittimità che, con ordinanza resa a Sezioni Unite n. 1419 del 01 febbraio 2012 emessa a seguito di un regolamento preventivo di giurisdizione promosso da un dirigente “dell’AMA spa, società interamente partecipata dal Comune di Roma, che svolge il servizio pubblico locale di nettezza urbana, per conto dello stesso comune”, ha “dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti”, per i danni dal primo inferti al patrimonio societario.
Le argomentazioni a sostegno di quella conclusione militano nel senso sin qui esposto.
Sin dalla sentenza resa a SS.UU. dal Giudice della Giurisdizione n. 6806 del 19 dicembre 2009, si è affermato il principio secondo cui “… il danno inferto dagli organi della società al patrimonio sociale, che nel sistema del codice civile può dar vita all’azione sociale di responsabilità ed eventualmente a quella dei creditori sociali, non è idoneo a configurare anche un’ipotesi di azione ricadente nella giurisdizione della Corte dei conti: perché non implica alcun danno erariale, … L’esattezza di tale conclusione trova conferma anche nell’impossibilità di realizzare, altrimenti, un soddisfacente coordinamento sistematico tra l’ipotizzata azione di responsabilità dinanzi giudice contabile e l’esercizio delle surriferite azioni di responsabilità (sociale e dei creditori sociali) contemplate dal codice civile… … Ne consegue che, trattandosi di società a partecipazione pubblica, il socio pubblico è di regola in grado di tutelare egli stesso i propri interessi sociali mediante l’esercizio delle suindicate azioni civili. Se ciò non faccia e se, in conseguenza di tale omissione, l’ente pubblico abbia a subire un pregiudizio derivante dalla perdita di valore della partecipazione, è sicuramente prospettabile l’azione del procuratore contabile nei confronti (non già dell’amministratore della società partecipata, per il danno arrecato al patrimonio sociale, bensì nei confronti) di chi, quale rappresentante dell’ente partecipante o comunque titolare del potere di decidere per esso, abbia colpevolmente trascurato di esercitare i propri diritti di socio ed abbia perciò pregiudicato il valore della partecipazione”.
Ed anche la Giurisdizione contabile è approdata a tali conclusioni.
La Sezione Terza Giurisdizionale d’Appello della Corte dei Conti, con decisione n. 453 del 23 giugno 2010, nel denegare la giurisdizione contabile, ha ritenuto che “nel caso di specie, come in quelli oggetto delle più volte richiamate pronunce SS.UU. Cass. n°26806/2009 e n°519/2010, il danno per il quale ha agito la Procura Regionale non pertiene direttamente al patrimonio dell’Ente Pubblico, ma a quello proprio della società partecipata: trattasi di danno che, a rigore, ha chiarito la Suprema Corte, neppure può qualificarsi “come danno erariale”, da intendere come “pregiudizio direttamente arrecato al patrimonio dello Stato o di altro Ente pubblico che della società (medesima) sia socio”, attesa “la ben nota distinzione tra la personalità giuridica della società di capitali e quella dei singoli soci e la piena autonomia patrimoniale dell’una rispetto agli altri”.
Ed analogamente, con sent. 261 del 09 aprile 2010, sempre la Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d’appello della Corte dei Conti ha denegato la giurisdizione contabile rilevando come “Con recente ordinanza n. 519 del 15 gennaio 2010 … le Sezioni Unite della Cassazione, risolvendo un conflitto preventivo di giurisdizione pro-posto dall’attuale appellante in altro giudizio che lo vede convenuto presso la Sezione giurisdizionale per la Lombardia, hanno infatti stabilito che la giurisdizione per l’azione di risarcimento danni cagionati al patrimonio di società partecipata da un Ente pubblico appartiene al Giudice ordinario e non alla Corte dei conti”.
Ecco perché non persuadono le conclusioni, pur raggiunte dalla isolata pronuncia della Cassazione (sent. 25 novembre 2013, n. 26283), in ordine all’assoggettamento alla giurisdizione contabile degli amministratori di società in house.
Quel precedente, infatti, non spiega come possa accordarsi l’azione del Procuratore erariale con “l’esercizio delle surriferite azioni di responsabilità (sociale e dei creditori sociali) contemplate dal codice civile”, a meno di ritenere che, per un medesimo fatto, per una medesima causa petendi e per un medesimo petitum, un soggetto possa essere giudicato, ed eventualmente, condannato al risarcimento del danno, due volte: in sede civile, ed in sede contabile, con grave vulnus ad uno dei principi cardine del nostro ordinamento: il ne bis in idem.
Quella decisione, non prendendo posizione sul punto, deve dunque essere coordinata con tale principio, e per dare coerenza al nostro sistema giuridico, ove rappresentasse il nuovo corso del Giudice della giurisdizione (al momento, si può parlare solo di un brusco revirement) deve essere interpretata nel senso che, per le società in house, l’azione contabile del Procuratore esclude quella sociale/civilistica dei soci contro gli amministratori infedeli: per dare coerenza al sistema, si deve ritenere che con quell’isolato precedente il Giudice della Giurisdizione ha voluto affermare che per le società in house, l’azione sociale di responsabilità, ordinariamente in capo ai soci, viene trasferita in capo alla Procura contabile.
Tale conclusione, però, a dispetto di quanto minoritariamente osservato dalla giurisprudenza di merito, non esclude la fallibilità di quei soggetti.
Ed infatti, quest’ultimo è istituto posto a tutela dei creditori della società, che agiscono non per il risarcimento del danno prodotto dall’amministratore, ma per la soddisfazione del proprio credito, e come si è più sopra visto, le norme derogatorie della ordinaria disciplina sono eccezionali, e quindi insuscettibili di applicazione analogica, e nessuna norma esclude dal fallimento le società in house.
Tale conclusione è poi corroborata dalle esigenze di tutela dei terzi, dei creditori della società e della certezza dei rapporti giuridici.
Si è osservato in giurisprudenza (Cass. civ. Sez. I, 07 marzo 1998, n. 2540), che “…. le esigenze di tutela della buona fede dei terzi della certezza dei rapporti giuridici rendono rilevante che il terzo sia consapevole che l’altro contraente abbia quella determinata qualità soggettiva (n.d.r., imprenditore commerciale) alla quale l’ordinamento ricollega l’assoggettabilità alla procedura fallimentare”.
Tutti gli istituti di pubblicità legale previsti dal codice civile in materia di società hanno tale finalità: tutelare i terzi, e dare certezza giuridica ai rapporti (cfr. art. 2331 c.c. sugli effetti dell’iscrizione nel registro dell’atto costitutivo; art. 2383 c.c. sulla iscrizione della nomina degli amministratori e sulla inopponibilità a terzi delle cause di nullità e/o invalidità dopo l’iscrizione; art. 2384 c.c. sulla iscrizione della cessazione degli amministratori; art. 2435 c.c. sul deposito del bilancio e del verbale di assemblea di approvazione; ecc.), tanto che, con norma di chiusura, l’art. 2448 c.c. stabilisce che “gli atti per i quali il codice prescrive l’iscrizione o il deposito nel registro delle imprese sono opponibili ai terzi soltanto dopo tale pubblicazione, a meno che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza”.
E’ dal momento dell’iscrizione, dunque, che il terzo viene a conoscenza del fatto rilevante, ed in ragione del numerus clausus dei contratti di società, è solo da quel momento che è in grado di effettuare valutazioni in ordine alle conseguenze giuridiche del fatto iscritto, avendo a disposizione il catalogo completo dei diritti e dei doveri applicabili: l’art. 2249 c.c. stabilisce che “le società che hanno per oggetto l’esercizio di un’attività commerciale devono costituirsi secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti di questo titolo”.
Tale disposizione contiene un divieto di costituzione di società atipiche (Di Sabato, Diritto delle società, Milano, 2003, 22; Associazione Preite, Il diritto delle società, Bologna, 2006, 31), e la ratio dell’esclusione della società semplice quale modello organizzativo per lo svolgimento dell’attività commerciale è stata rintracciata nella circostanza che la disciplina dei tipi commerciali è caratterizzata da una più accentuata protezione dei creditori sociali (Marasà, Le società, I, Società in generale, Milano, 2000, 248).
Tali considerazioni militano per l’assoggettabilità a fallimento anche delle società in house.
Infatti, come visto sopra, il modello dell’in house è di origine pretoria, nato esclusivamente come deroga al principio della doverosità delle gare pubbliche.
Non esiste, nel nostro ordinamento, un tipo societario ad hoc, e volta per volta le società costituite da enti pubblici, assumono una delle tipologie previste dal codice civile (s.r.l., s.p.a. ecc.), con conseguente applicazione del relativo catalogo di norme.
Per l’ordinamento, la scelta del tipo societario prescelto deve essere portata a conoscenza dei terzi: si veda l’art. 2292 c.c. per le società in nome collettivo (“La società in nome collettivo agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di uno o più soci con l’indicazione del rapporto sociale”), l’art. 2314 c.c. per le società in accomandita semplice (“La società agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l’indicazione di società in accomandita semplice, salvo il disposto del secondo comma dell’articolo 2292”), art. 2326 c.c. per le società per azioni (“La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di società per azioni”), art. 2453 c.c. per le società in accomandita per azioni (“La denominazione della società è costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l’indicazione di società in accomandita per azioni”), art. 2463 c.c. per le società a responsabilità limitata (“la denominazione, contenente l’indicazione di società a responsabilità limitata…”).
E’, dunque, una costante nel nostro ordinamento l’indicazione del tipo societario, ciò in quanto l’indicazione del rapporto sociale è ritenuta dalla legge necessaria in relazione all’esigenza che i terzi siano concretamente posti a conoscenza del tipo di società.
Le società in house non costituiscono una species del genus societario, ma assumono, volta per volta, la struttura di uno dei “tipi” previsti dal codice. Prova ne sia la circostanza che non esiste alcuna norma di diritto positivo che obblighi l’indicazione, nella denominazione sociale, o in altri atti, della dizione “in house”, di talché il terzo che entra in contatto con tale società, è in grado esclusivamente di sapere se sta contrattando con una s.p.a. o con una s.r.l.
Tale conclusione deriva dal fatto che la natura in house della società non deriva da un dato formale che deve essere portato a conoscenza dei terzi ex ante, ma da un accertamento fattuale, rimesso ex post alle Aule di Giustizia, che faticosamente devono verificare l’esistenza, in fatto, del controllo analogo (analizzando Statuto, delibere degli Enti, atti amministrativi generali, patti parasociali), e dell’esercizio prevalente dell’attività in favore degli Enti partecipanti. Accertamento, questo, che non può essere svolto dai terzi che entrano in contatto con quel soggetto giuridico.
E’ dunque la tutela dell’affidamento dei terzi che impone l’applicazione indiscriminata, alle società in house, del catalogo di norme previste dall’ordinamento per la tipologia societaria prescelta, e portata a conoscenza della collettività.
Escludere dall’assoggettabilità a fallimento le società in house, significa:
- violare l’art. 2249 c.c.;
- interrompere i traffici commerciali;
- ledere l’ordine pubblico economico.
Dal primo punto di vista, stabilire che una s.p.a. in house non possa essere soggetto a fallimento, significare combinare due cataloghi di norme (quelle dell’imprenditore commerciale, e quelle dell’imprenditore agricolo), in violazione del principio di tassatività dei tipi societari: si crea, così, un nuovo contratto societario, in chiara violazione dell’art. 2249 c.c., con l’aggravante che verrebbe lasciato all’interprete l’individuazione, volta per volta, di quale norma applicare al caso concreto.
Dal secondo punto di vista, nessun fornitore assumerebbe il rischio di contrattare con una società partecipata da enti pubblici, sapendo che in caso di crisi, potrebbe essergli opposta la natura in house, prima mai dichiarata.
Dal terzo punto di vista, si può osservare che potendo le società affidatarie, in via diretta, di commessa pubbliche, operare in settori economici non soggetti a “privativa pubblica”, nei quali, pertanto, concorrono anche soggetti “privati”, l’esclusione dal fallimento delle prime, comporta la creazione di sacche di impunità, e di privilegio, non potendo essere espulse dal mercato di riferimento soggetti decotti, con grave vulnus all’ordine pubblico economico, inteso come regolare ed ordinato svolgimento dei rapporti economici, un cui corollario è l’espulsione dal mercato di soggetti non economici, ossia di soggetti che assorbono risorse e non producono ricchezza.
E’ evidente che, indipendentemente dalla natura in house che dovesse un giorno essere riconosciuta in capo ad una società interamente o parzialmente partecipata da un Ente pubblico, avendo quest’ultima assunto il ruolo di imprenditore commerciale, ad essa andrà applicato l’intero catalogo delle norme positive previste dall’ordinamento, ivi compreso il fallimento.