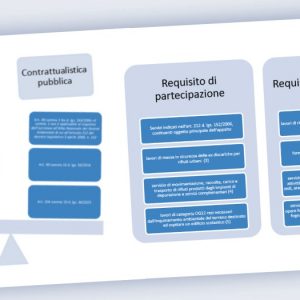A cura dell’Avv. Clelia Di Jeso
La sentenza n. 119 del 2023, che ha ad oggetto il tema dell’alienabilità di terreni gravati da usi civici, appare di particolare rilievo perché la Consulta ribadisce la centralità del diritto di proprietà e l’impossibilità che tale diritto possa soffrire irragionevoli svilimenti sotto la vigenza dell’art. 42 della Costituzione. Il potere di vendere il bene immobile è il contenuto stesso del diritto dominicale (cioè del diritto del dominus) anche qualora il fondo sia destinato a uso civico.

È necessario addentrarsi nel mondo degli usi civici per capire la sentenza.
Gli usi civici sono tecnicamente dei diritti reali atipici (in quanto non espressamente previsti dal codice civile) con caratteristiche simili all’enfiteusi e alla servitù e fanno capo alla comunità locale nel cui territorio è situato il fondo su cui gravano. Questi diritti possono insistere su un bene demaniale, e allora il diritto in re propria non pone problemi perché – per tabulas, ex art. 823 cod. civ. – il bene demaniale è inalienabile. È quindi ininfluente la presenza sullo stesso degli usi civici. Se, invece, il diritto di uso civico grava sul fondo di proprietà del privato (iura in re aliena), ci si chiede se il bene possa circolare. A questo interrogativo risponde affermativamente la sentenza in commento.
Quando si parla di usi civici, vengono in rilievo boschi, zone agricole tradizionali, corsi d’acqua e aree destinate a pascolo naturale come ad esempio il “Bosco Grappidà – Finocchiaro – Gelso” del demanio civico di Bronte in Sicilia (oggetto del parere delle Sezioni riunite del Consiglio di Giustizia amministrativa per la regione siciliana del 15.3.2022). Si tratta di aree sulle quali la comunità locale esercita da tempi antichissimi, se non da almeno un millennio, il diritto di raccogliere la legna, far pascolare e abbeverare il bestiame, pescare, raccogliere frutti o semplicemente il diritto di passaggio. La giurisprudenza ha affermato che gli usi civici sono diritti fondamentali storici di cui la persona gode sia come singolo, sia quale parte della formazione sociale cui appartiene (ex art. 2 della Cost.). Anzi, a ben vedere, gli usi civici riguardano proprio la dimensione collettiva della persona. L’individuo è titolare del diritto di godere delle terre vincolate ad uso civico, solo nella veste di membro della comunità locale. Si valorizza, così, l’identità dei luoghi e si conserva l’ambiente nella sua originaria idea: quale elemento in perfetta integrazione con l’uomo. Infatti, secondo alcuni autori, l’uso civico è un attributo giuridico degli antichi terreni feudali. È la storia che ci dice che determinati terreni all’interno della realtà feudale venivano predisposti per gli usi necessari ad assecondare i bisogni della popolazione locale, nel rispetto della naturale vocazione delle terre. In questa prospettiva, l’ambiente si lega alle esigenze della collettività che si obbliga, da parte sua, a conservare la destinazione delle terre. Tutto ciò si osserva anche nel rispetto di una “comproprietà inter-generazionale” (come efficacemente definita dall’art. 1, comma 1, lett. c) della L. 168 del 2017 ricordata dalla sentenza n. 236 del 2022 della Corte Costituzionale).
Da quanto sopra esposto emerge che le aree gravate dagli usi civici sono aree protette perché strettamente legate agli interessi di salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio. La vocazione ambientalista/paesaggistico degli usi civici è chiaramente affermata dalla Legge n. 168 del 2017 all’art. 3, comma 6. Si legge, infatti, che il vincolo paesaggistico (quello apposto sulle zone gravate da usi civici) garantisce l’interesse della collettività generale alla conservazione degli stessi contribuendo alla salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio. Il legame tra ambiente, paesaggio e usi civici viene così consacrato, ma questo non è un fatto nuovo. Infatti, anche da precedenti disposizioni normative emergeva tale collegamento. Prima l’art. 1, comma 1, L. 431 del 1985, poi l’art. 142, comma 1, lett. h) del codice dei beni culturali e del paesaggio avevano sottoposto a vincolo paesaggistico tutte le zone destinate a usi civici e le aree assegnate alle università agrarie (concetto ribadito in più sentenze della Corte, ex multis sent. N. 228 del 2021).
Chiarita quindi, la definizione degli usi civici e riscontrato che i beni gravati dagli stessi sono beni paesaggisticamente vincolati, la Consulta afferma che tali beni, anche se non sono stati oggetto del procedimento di liquidazione disciplinato dalla Legge n. 1766 del 1927, possono essere oggetto di vendita immobiliare forzata e, a più forte ragione, possono essere oggetto di compravendita consensuale. In sostanza, non si applica a detti beni il regime della inalienabilità (stabilito dall’art. 3, comma 3, L. 168 del 2017) che opera, invece, per il demanio civico detto anche patrimonio civico. È necessario ricordare, infatti, che il criterio dell’appartenenza non è sufficiente a cogliere la differenza tra proprietà pubblica e privata. Ad esempio, tra i beni di proprietà pubblica, solamente quelli demaniali e del patrimonio indisponibile sono inalienabili. Per converso, alcuni beni di proprietà privata (si pensi ad autostrade costruite dai privati, boschi privati, beni vincolati), attesa la finalità pubblicistica, sono assoggettati ad un regime particolare.
L’iter argomentativo seguito dal giudice a quo nella sua ordinanza di rimessione della questione di legittimità costituzionale in via incidentale si articola con riferimento agli artt. 3, 24 e 42 della Costituzione. La censura più importante, però, attiene alla intrinseca irragionevolezza del regime della inalienabilità in considerazione del fatto che tale restrizione alla proprietà privata non è funzionale ad assicurare il godimento da parte della collettività del bene gravato da uso civico. Infatti l’alienazione non determina, di per sé soltanto, la cessazione del diritto reale parziario in re aliena, sicché sarebbe del tutto irrilevante per la comunità di riferimento dell’uso civico, la titolarità del diritto dominicale sul bene. Emerge, quindi, la manifesta irragionevolezza del divieto di alienazione. L’interesse della collettività che il legislatore tutela attraverso il riconoscimento degli usi civici è svincolato dalle vicende circolatorie del bene: gli usi civici, gravando sul bene, circolano con esso.
È tuttavia necessario sottolineare che gli usi civici in re aliena conformano il contenuto del diritto di proprietà perché chiunque acquisti il fondo non può compiere alcun atto che possa compromettere il pieno godimento promiscuo delle terre. È, quindi, impedito al proprietario apportare modifiche consistenti nella divisione del fondo, nella realizzazione di interventi che ostacolino la fruizione collettiva, o nella trasformazione che realizzi una sottrazione di terreno.
Originariamente questa peculiare modalità di godimento del fondo, al tempo stesso congiunta e riservata, veniva guardata con sfavore perché imperava l’idea che ciò ostacolasse la massima produttività del fondo. Perciò, il legislatore del 1927 prevedeva un procedimento per “liquidare” queste forme di utilizzo collettivo del bene. Non solo gli usi civici ma “qualsiasi diritto di promiscuo godimento delle terre”, tra cui le comunioni generali per servitù reciproche, le università e le altre associazioni agrarie comunque denominate.
I commissari regionali (con funzioni sia amministrative sia giudiziarie) accertavano l’esistenza, la natura e l’estensione del diritto spettante agli abitanti del Comune e, su istanza del proprietario, lo liquidavano, liberando così il fondo dal relativo peso. Il proprietario perdeva, in favore del Comune, una porzione del fondo, più o meno estesa in considerazione del tipo di diritto civico – di prima o seconda classe (se era un diritto essenziale o solo utile al sostentamento degli abitanti di quel Comune)- ma otteneva la riespansione del proprio diritto dominicale.
In alcuni casi, l’apporzionamento del fondo al Comune non poteva aver luogo perché il proprietario aveva apportato al fondo sostanziali e permanenti migliorie (art.7). Quindi, la proprietà rimaneva nelle sue mani e questi corrispondeva al Comune un canone annuo di natura enfiteutica. In sostanza si saltava il passaggio in cui la proprietà del fondo passava all’amministrazione. Atteso, infatti, che il fine ultimo del legislatore, dopo il passaggio di proprietà nella mano pubblica, vedeva la realizzazione di una privatizzazione, questa veniva sostanzialmente già realizzata nella fattispecie sopra descritta (oltre che nell’altra fattispecie peculiare delle occupazioni sine titulo legittimate ex art.9). Tralasciando le ipotesi eccentriche, il Comune -divenuto proprietario- distingueva i terreni in due categorie (art.11). Quelli destinati a bosco o pascolo permanente che entravano a far parte del demanio comunale, e quelli destinati alla coltura agraria. Questi ultimi erano oggetto di ripartizione: venivano divisi e le singole unità fondiarie venivano assegnate -a titolo di enfiteusi, dietro pagamento del canone- alle famiglie di coltivatori diretti del Comune, con preferenza per quelle meno abbienti, purché avessero dato affidamento di trarne la maggiore utilità (art.13).
Dalla lettura di tale procedimento, emerge che il diritto civico gravante su un bene di proprietà privata si estingue allorché il Comune (in qualità di ente esponenziale della comunità locale e di titolare del diritto di uso civico) si veda “liquidare” detto diritto. L’intervento del legislatore del 1927 era quello di dismettere gli usi civici sui terreni a vocazione agricola e privatizzarli. Invece, per i terreni destinati a bosco o a pascolo permanente, la legge prevedeva la conservazione dei diritti della popolazione e subordinava l’alienazione e il cambio di destinazione al rilascio del provvedimento autorizzatorio del Ministero dell’economia nazionale (art. 12).
Oggi, la legge del 2017 sul riconoscimento dei domini collettivi muove da una diversa premessa, cioè quella di valorizzare la proprietà collettiva. Si crea così un netto contrasto tra i due interventi normativi. Tuttavia, la sentenza della Corte Costituzionale in commento, nell’affermare la validità di vendite di terreni gravati da usi civici non ancora liquidati (dichiarando parzialmente incostituzionale la disposizione de qua), sembra trovare un punto di equilibrio tra le due diverse impostazioni normative. Da un lato, la Corte difende il diritto del proprietario di vendere il proprio bene (nonostante sia gravato da uso civico), dall’altro dà tutela alla fruizione collettiva del bene, ribadendo l’assenza di qualsiasi nesso logico tra le vicende circolatorie del bene e l’esercizio dei diritti civici.
La decisione della Corte interseca la categoria dei “beni pubblici” che è di difficile individuazione tanto che oggi se ne sollecita una rivisitazione. Perciò, per un migliore approfondimento, si rimanda allo scritto del Prof. Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente del Consiglio di Stato. In questa sede è, tuttavia, funzionale un richiamo ad un recente orientamento giurisprudenziale che supera i confini dell’oramai datata prospettiva del dominium dei romanisti. Questo orientamento riconosce che vi sono beni che, “essendo strumentalmente collegati alla realizzazione degli interessi di tutti i cittadini, debbono essere considerati comuni prescindendo dal titolo di proprietà”. È chiaro che, in tal modo, si rompe il tradizionale rapporto tra soggetto ed oggetto e la tutela del bene viene svincolata da qualsiasi riferimento ad un profilo di titolarità. Nel 2017 la relazione della Commissione presieduta dal prof. Rodotà (incaricata dal ministero della Giustizia di elaborare un disegno di legge delega per la modifica delle norme del codice civile in materia di beni pubblici) qualifica i beni pubblici come “le cose che esprimono utilità funzionale all’esercizio dei diritti fondamentali, nonché al libero sviluppo della persona”, ribadendo l’irrilevanza del regime proprietario.
Anzi, secondo Lipari, l’alternativa pubblico-privato non è più in grado di assorbire tutta la teoria dei beni, perché vi sono alcuni beni così intimamente connessi alle più essenziali esigenze di vita dell’uomo che si sottraggono a qualunque forma appropriativa, non potendo che appartenere a tutti. Rispetto a tali beni è più corretto parlare di riconoscimento e non di attribuzione-concessione alla collettività da parte dell’ordinamento. Secondo tale autore si tratta di un criterio qualificativo che va al di là dello stesso principio consegnatoci dall’art. 42 della Costituzione circa la funzione sociale della proprietà, e che non si riconnette in alcun modo ad obblighi o comportamenti imposti al titolare.
Attraverso questa breve esposizione del recente orientamento giurisprudenziale, si ritiene che possa meglio comprendersi la sentenza in commento che scinde il concetto di proprietà da quello di gestione della stessa. Inoltre, da tale prospettiva sembra si possa meglio apprezzare l’origine storico-identitaria degli usi civici.
In conclusione, la Consulta ribadisce la centralità della proprietà privata e sollecita una riflessione sulla categoria dei beni pubblici. La giurisprudenza più attenta parla, infatti, di “beni comuni” per intendere quei beni la cui ontologica fruizione è diffusa e non esclusiva, quei beni che sono intrinsecamente sottratti ad ogni forma di titolarità sia di natura pubblica che privata. Rimane solo da chiedersi se le nuove o, meglio, ritrovate esigenze identitarie e ambientali tutelino gli usi civici nel pieno rispetto del diritto di una proprietà conformata.
In un ordinamento giuridico in cui non esistono diritti tiranni, questo è il punto di equilibrio fissato dal giudice delle leggi tra interessi individuali e collettivi-generali.
Scarica sentenza completa (PDF)