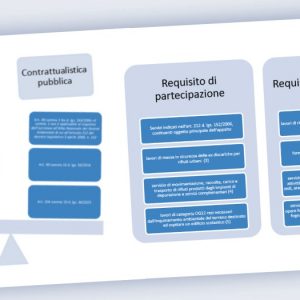A cura dell’avv. Nicoletta Tradardi
Il principio “chi inquina paga” costituisce uno dei cardini della disciplina di matrice comunitaria in materia ambientale: «la politica dell’Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell’Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell’azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché sul principio “chi inquina paga”». L’enunciato è sancito dal TFUE (art. 191 co. 2).

In applicazione del principio «chi inquina paga», l’operatore che provoca un danno ambientale o è all’origine di una minaccia imminente di tale danno è tenuto di massima a sostenere il costo delle necessarie misure di prevenzione o di riparazione (cfr. Dir. 21-4-2004 n. 2004/35/CE, Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale).
«Secondo il principio “chi inquina paga”, i costi della gestione dei rifiuti, compresi quelli per la necessaria infrastruttura e il relativo funzionamento, sono sostenuti dal produttore iniziale o dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti» (cfr. Dir. 19-11-2008 n. 2008/98/CE, Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive).
Due pronunce della CGUE in tema dei rifiuti, entrambe sul principio del “chi inquina paga”, e relative al nostro ordinamento interno, offrono l’occasione per riflettere sulle diverse declinazioni che esso può assumere.
Un primo profilo prende in considerazione le sentenze della CGUE nell’ambito della procedura di infrazione sulle cd. “discariche abusive”. La vicenda è nota: la Commissione UE avviava una procedura di infrazione (P.I. 2003/2077) nei confronti della Repubblica Italiana, per la gestione del ciclo dei rifiuti, nell’ambito della quale la Corte di Giustizia ha dapprima, con sentenza del 26 aprile 2007 n. 135 (causa C-135/05), accertato l’inadempimento della Repubblica Italiana agli obblighi su di essa gravanti; quindi, con sentenza del 2 dicembre 2014 n. 196 (causa C-196/13), perdurando l’inadempimento, ha applicato una serie di sanzioni pecuniari.
La sentenza n. 135 del 2007, premette che ai sensi dell’art. 4 della direttiva 75/442, gli Stati membri sono chiamati ad adottare le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente; la norma. peraltro, non precisa il contenuto concreto delle misure che devono essere adottate per assicurare tale obiettivo. La disposizione vincola gli Stati membri quanto all’obiettivo da raggiungere, lasciando agli stessi un potere discrezionale nella valutazione della necessità di tali misure (§ 37).
L’esistenza sul territorio italiano, per un periodo prolungato di tempo, sia di un considerevole numero di discariche, in cui i gestori non avevano garantito il riciclaggio o lo smaltimento dei rifiuti secondo le modalità di cui al richiamato art. 4, sia di numerosi siti di smaltimento incontrollato di rifiuti, ha avuto necessariamente per conseguenza un degrado rilevante dell’ambiente (§ 39 e 40). Per tali ragioni, la Repubblica Italiana è stata condannata, non avendo adottato tutti i provvedimenti necessari, da un lato, per assicurare che i rifiuti fossero recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che avrebbero potuto recare pregiudizio all’ambiente e, dall’altro, per vietare l’abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti.
Questa prima pronuncia ha ritenuto responsabile lo Stato Italiano per non aver assunto quelle misure (in primis: normative) idonee a non consentire sul suo territorio la permanenza di discariche non conformi alla normativa comunitaria, mentre non assumeva rilievo che esse operassero in forza di autorizzazione o meno e, più in generale, se esse operassero in una condizione di legittimità alla stregua dell’ordinamento interno.
Non avendo adottato tutte le misure necessarie a dare esecuzione a questa sentenza, la Repubblica Italiana con la decisione n. 196 del 2014, è stata condannata dalla CGUE al pagamento di sanzioni pecuniarie.
Il Giudice comunitario ha osservato in quest’ultima sede, che “nella sentenza Commissione/Italia (EU:C:2007:250), la Corte ha constatato un inadempimento di carattere generale e persistente … la Corte ha avuto l’occasione di giudicare, da un lato, che un degrado dell’ambiente è intrinseco alla presenza di rifiuti in una discarica, a prescindere dalla natura dei rifiuti di cui trattasi, e, dall’altro, che la mera chiusura di una discarica o la copertura dei rifiuti con terra o detriti non è sufficiente per adempiere agli obblighi derivanti in particolare dall’articolo 4 della direttiva 75/442. … Ai sensi di detto articolo 4 uno Stato membro è altresì obbligato a verificare se sia necessario bonificare le vecchie discariche abusive e, all’occorrenza, a bonificarle. … Per ottemperare agli obblighi derivanti dagli articoli 4, 8 e 9 della direttiva 75/442 non è sufficiente chiudere tutte le discariche interessate”.
La sentenza n. 196 del 2014, si basa su di un‘interpretazione tranciante del principio “chi inquina paga”: la (persistente) presenza di discariche chiuse, ma per le quali non sia stata verificata la necessità della bonifica, è di per sé causa di inadempimento, in quanto comporta la presenza di siti non conformi alla disciplina comunitaria. La presenza di una serie di presupposti oggettivi (nel senso di elementi non aderenti alla norma comunitaria, a prescindere dalle cause della difformità), implica l’applicazione del principio “chi inquina paga”.
La seconda decisione della CGUE da esaminare è la n. 15 del 14 maggio 2020 in Causa C-15/19 (Ama – Azienda Municipale Ambiente spa c/ Co.La.Ri – Consorzio Laziale Rifiuti). Anch’essa riguarda tematiche inerenti le discariche di rifiuti. In questo caso, il Giudice comunitario, chiamato a valutare la problematica del soggetto su cui incombono gli oneri della gestione post mortem, ha affermato il seguente principio ”gli articoli 10 e 14 della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, devono essere interpretati nel senso che non ostano all’interpretazione di una disposizione nazionale secondo la quale una discarica in funzione alla data di recepimento di detta direttiva deve essere assoggettata agli obblighi derivanti da quest’ultima, segnatamente a una proroga del periodo di gestione successiva alla chiusura, senza che occorra distinguere in base alla data in cui i rifiuti sono stati abbancati né prevedere alcuna misura intesa a contenere l’impatto finanziario di tale proroga sul detentore dei rifiuti”.
Ai sensi dell’art. 10 della Direttiva 1999/31/CE, gli Stati membri debbono assicurare che i costi stimati di chiusura della discarica e di gestione successiva alla chiusura, per un periodo di almeno 30 anni, siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento di qualsiasi tipo di rifiuti nella discarica. Quindi, il gestore di una discarica in funzione al momento del recepimento della Direttiva deve garantire, per almeno 30 anni, la gestione post – mortem. Le conseguenze finanziarie derivanti dalla fissazione o dall’estensione a 30 anni del periodo di gestione post – mortem, devono gravare sui detentori dei rifiuti. Si tratta di un’espressione del principio «chi inquina paga». Far gravare sui gestori tali oneri condurrebbe – osserva la CGUE – ad imputare ai medesimi i costi connessi allo smaltimento di rifiuti che essi non hanno prodotto, ma di cui garantiscono lo smaltimento nell’ambito della loro attività di prestatori di servizi.
Così brevemente riassunti i contenuti delle decisioni, se esse se si pongono a confronto, sembra che il principio “chi inquina paga” sia stato oggetto di due diverse interpretazioni. Nel caso delle sentenze relative alla procedura d’infrazione per le discariche cd. abusive, il principio è applicato in modo assertivo: l’inadempimento della Repubblica Italiana è, innanzitutto, normativo e la sanzione pecuniaria – conseguenza del principio “chi inquina paga” – è stata inflitta per questo inadempimento (si prescinde, cioè, dalle circostanze concrete, ad esempio dalla eventuale necessità di bonifica o meno dei singoli siti).
Invece, nella sentenza n. 15 del 2020 l’applicazione del principio appare più lineare: il detentore del rifiuto è il soggetto che “inquina” (ma, sul punto, infra); su questi grava l’onere finanziario connesso alla gestione post mortem.
Dal raffronto fra le due pronunce può ritenersi che la GCUE, nella sentenza n. 15 del 2020, ha svolto, rispetto alla sentenza di condanna n. 196 del 2014, una riflessione più ponderata, più attenta al caso concreto, risolvendosi il principio nel “chi effettivamente inquina, paga”. Un mutamento di questo tipo, della giurisprudenza comunitaria, sarebbe apprezzabile, almeno ad avviso di chi scrive, non essendo esente da perplessità la soluzione accolta nella sentenza n. 196 del 2014.
Tuttavia, partendo dal diverso assunto di unitarietà e continuità della giurisprudenza comunitaria sul punto, potrebbe profilarsi una prospettiva diversa.
Nelle decisioni relative alla procedura di infrazione sulle discariche abusive, il principio “chi inquina paga” è inteso come strumento afflittivo: la sanzione non si identifica con il “costo” economico dell’inquinamento, ma è irrogata per la non conformità alla disciplina comunitaria (ed infatti, le relative somme non vengono corrisposte alle comunità che hanno subito le conseguente dell’inquinamento, bensì alla Commissione Europea). Nel caso della sentenza n. 15 del 2020 il principio “chi inquina paga” assume una valenza di maggiore neutralità, perché si risolve in termini economici. Gli oneri finanziari della gestione post mortem gravano sul detentore di rifiuti perché questi ha prodotto il rifiuto poi conferito in discarica. In questo caso, l’applicazione del principio risulta (o, almeno, così sembra a chi scrive), scevra da un giudizio di (dis)valore.
Questa prospettiva configura un duplice ambito di operatività giuridica del principio “chi inquina paga”: da un lato, una funzione repressiva, in un contesto risarcitorio, una volta che il danno si sia verificato; dall’altro, una funzione (non necessariamente preventiva, come insegna la sentenza CGUE n. 15 del 2020), finalizzata a ricondurre i costi ambientali fra quelli produttivi a carico dell’imprenditore, così da incentivare politiche aziendali virtuose sotto il profilo ambientale.
La Repubblica italiana è stata condannata al pagamento della sanzione di 40 milioni di euro e alla penalità di euro 42.800.000 per ogni semestre di ritardo nella piena esecuzione della precedente sentenza del 2007 (C- 135/05).
D’altro canto, il principio “chi inquina paga” ha fatto il suo primo ingresso, negli anni ’70 dello scorso secolo, proprio nel campo economico, come criterio generale di razionalità economica, per ricondurre fra i costi dei fattori di produzione anche quelli gravanti sull’imprenditore nell’eventualità del danno ambientale. In tal modo, l’imprenditore è incentivato ad esaminare nel miglior modo possibile i rischi ambientali conseguenti alla propria attività.